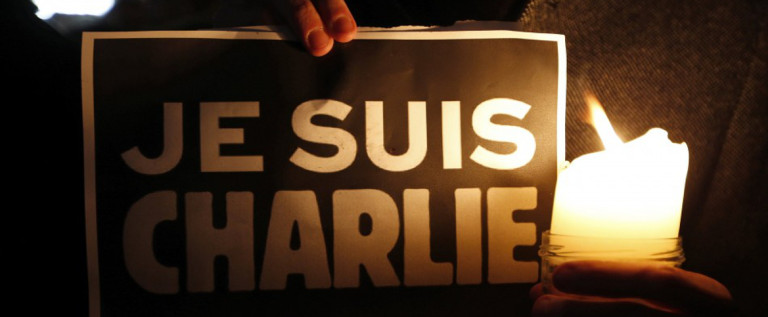Dopo le due guerre e il trauma della disfatta militare del 1940, la Francia della quinta Repubblica prese una decisione per sempre: finanziare con generosità le famiglie per ogni nuovo nato, in modo da non avere mai più una popolazione e dunque un esercito meno numerosi della Germania. La scommessa è riuscita, osserva Thomas Piketty nel suo libro «Il capitale nel XXI secolo». Secondo lo scenario di base delle Nazioni Unite, alle tendenze attuali la popolazione francese dovrebbe superare quella tedesca prima del 2050. La prima a 77 milioni di abitanti, in crescita di circa dieci, la seconda a 71 milioni e in decrescita di altri dieci.
Jens Weidmann, il quarantaseienne presidente della Bundesbank, a quel punto sarà un venerabile pensionato: uno dei 67 che la Repubblica federale dovrà mantenere per ogni cento persone in età da lavoro (l’Italia avrà uno squilibrio simile). Per adesso però Weidmann è ancora uno dei più giovani banchieri centrali d’Europa e nella sua recente intervista a Repubblica ha parlato anche di questo, benché pochi in Italia sembrino essersene accorti: la Germania, ha osservato, deve ridurre il suo debito perché sta invecchiando e presto avrà bisogno di risorse per mantenere e curare i suoi anziani.
Si può non essere d’accordo con il leader della Bundesbank, non però negare che i tedeschi stiano pensando in termini strategici. Lo fanno al pari della Francia gollista del secondo dopoguerra. Con i suoi effetti di onda lunga, che viene da lontano e approda lontano, la demografia è quanto di più vicino esista a un destino ineluttabile. Per questo in alcuni dei Paesi intellettualmente più avanzati ci si inizia a preparare ad alcune prospettive che somigliano da vicino a delle certezze. Eccone alcune: secondo le proiezioni dell’Onu, per effetto della caduta delle nascite e dell’invecchiamento, nel 2050 la Germania avrà perso 13 milioni di lavoratori autoctoni; l’Italia ne avrà persi dieci; e se il tasso di fertilità e la chiusura ai migranti continua così come oggi, secondo stime dello stesso governo di Tokyo, la popolazione giapponese crollerà dai 120 milioni attuali a 40 milioni fra un secolo. Nel 2014 e il Giappone ha perso 268 mila abitanti grazie al saldo negativo fra nuove nascite e decessi peggiore di sempre.
Queste sono realtà che incidono nel lungo periodo ma impongono ai Paesi ricchi di correre ai ripari subito. C’è chi lo sta facendo. Proprio la Germania, uno dei Paesi più colpiti dall’invecchiamento, è prima al mondo nel puntare sempre di più sull’istruzione dai primi anni di età: poiché le persone in età da lavoro saranno sempre di meno, l’obiettivo adesso è rendere da subito gli adulti del 2050 più capaci di produrre e portare crescita economica. Per questo Basf, leader mondiale della chimica, si è messa al centro di un club di 123 imprese tedesche, dalle medio-piccole a colossi come Daimler, Continental o Boehringer Ingelheim Pharma, in un progetto che hanno chiamato Wissensfabrik : la fabbrica della conoscenza. Non sono solo annunci di buone intenzioni, una fabbrica da convegni. Il gruppo di aziende si è anche collegato a decine di università e centri di formazione, ma soprattutto ha stretto rapporti con qualcosa come 162 scuole materne in Germania, quasi mille scuole elementari, centinaia di medie e di istituti superiori di ogni tipo. Insieme, stabiliscono programmi per bambini fin dalla prima infanzia – uso delle lingue, numeri, strumenti digitali – destinati a rendere gli allievi adulti più capaci in futuro. Una Germania con sempre meno lavoratori pensa già a mettere quelli dei prossimi decenni in condizione di diventare più produttivi.
Alla base di Wissensfabrik c’è la scoperta che è valsa il Nobel per l’Economia a James Heckman, dell’Università di Chicago. Heckman ha seguito un gran numero di persone fin dalla prima infanzia e per decenni. All’inizio ha misurato che nella primissima età scolare i bambini con genitori disoccupati ascoltavano 3 milioni di parole l’anno, quelli con genitori occupati in mestieri umili 6 milioni di parole e i figli di professionisti laureati 11 milioni. Lo scarto fra loro era già enorme all’età di ingresso nella scuola materna: i figli di disoccupati disponevano di un vocabolario di non oltre 500 parole, quelli di genitori con mestieri poco qualificati di 700 parole, mentre i figli dei laureati arrivavano a 1.100. Soprattutto, seguendo il suo gruppo-campione, Heckman ha notato che questo scarto apertosi fra bambini del primo anno dell’asilo sembrava non chiudersi più. Al contrario, negli anni e nei decenni tendeva a crescere. Il livello cognitivo all’età di tre anni, collegato alla cultura della famiglia di origine, permetteva dunque di prevedere il successo nella vita per qualifiche, produttività, reddito, stabilità familiare, salute o la capacità di evitare il vizio del fumo o di obesità.
Per questo Heckman pensa che la «predistribuzione» sia più efficace della redistribuzione: programmi educativi rivolti alla prima infanzia, quando la capacità di assorbimento degli allievi e la loro permeabilità all’istruzione è massima, in modo offrire a tutti opportunità simili. Insegnare alle persone a usare il cervello quando il cervello è più ricettivo all’insegnamento. L’intervento del welfare classico è sì necessario, ritiene Heckman, ma costa di più ed è meno efficace.
L’alleanza fra imprese e scuole in Germania è la prima applicazione della teoria di Heckman a un grande Paese sul quale grava la nube dell’invecchiamento. L’intenzione è preparare una generazione di tedeschi a far funzionare quella che viene chiamata Industrie 4.0 : gli impianti che fra dieci o vent’anni saranno robottizzati e funzioneranno grazie all’integrazione di sistemi meccanici e digi- tali. Anche a migliaia di chilometri distanza, le macchine di un gruppo globale si invieranno segnalazioni automatiche sullo stadio di produzione, le catene di fornitura, il livello degli stock o il rischio di guasti nel sistema.
Il piano scuola che il governo di Matteo Renzi sta elaborando per ora non tiene conto di tutto questo. Eppure l’Italia è uno dei Paesi che invecchia più in fretta: nel 2014 sono nati oltre 70 mila bebé meno che nel 2008. Certo esiste un’altra strada per compensare il crollo delle nascite, l’immigrazione. Ma poiché la crescita è tanto frutto del numero di lavoratori attivi che della loro produttività, è determinante per l’economia che gli stranieri in arrivo siano persone qualificate. Una banca dati presente da qualche giorno sul sito di Eurostat, l’agenzia statistica europea, fa capire che questa selezione avviene. Ma non per tutti i Paesi nella stessa misura. In Germania ha una laurea (o titolo equivalente) il26% degli stranieri residenti, in Francia il 22%, in Italia solo il 14%. Questi numeri non sembrano casuali: corrispondono quasi esattamente alla quota dei laureati rispettivamente tedeschi, francesi e italiani sul totale della popolazione nazionale dei tre Paesi. In sostanza tanto più è alto il livello di istruzione di una società, quanto più quella società riesce ad attrarre persone qualificate anche da fuori. Dove l’istruzione è meno diffusa, anche i migranti che arrivano e si trattengono sono meno preparati, meno produttivi e dunque meno utili all’economia. La Gran Bretagna in questo ha una strategia che sembra vincente, perché attrae stranieri più istruiti della media degli stessi britannici. I «nativi » con una laurea sono il 24%, gli stranieri residenti con un titolo di studio superiore invece sono il 42% del totale degli immigrati.
Mentre i Paesi avanzati invecchiano, queste realtà conteranno ogni anno di più e produrranno anche nuove opportunità: in Giappone la carenza di uomini sta già aprendo alle donne professioni tradizionalmente riservate agli uomini come le costruzioni o la guida dei camion. L’invecchiamento porterà opportunità anche nell’innovazione industriale: quando gli ultra-settantenni saranno oltre un quarto della popolazione in Europa o in Giappone, nota l’economista dell’Università di Tokyo Hiroshi Yoshikawa, richiederanno ogni sorta di sistemi e robot disegnati per le loro esigenze: auto, appartamenti, apparecchi medici e di cura personale, modalità di viaggio adatte a loro. Il Boston Group, un consulente industriale, prevede che il giro d’affari della vecchiaia varrà da 8 mila miliardi di dollari di qui a metà secolo. Forse Weidmann dunque ha torto a pensare che l’invecchiamento imponga soprattutto di risparmiare: ma lui, almeno, ha iniziato a porsi il problema.